
Al fòcu
Il fòcu era il più spettacolare dei vecchi giochi che contrapponevano due squadre. Specialmente all’inizio, quando entrambe erano ancora al completo o quasi, proponeva fasi di grande concitazione perché i giocatori in azione contemporaneamente potevano essere numerosi e perché la posizione di vantaggio poteva passare istantaneamente da una squadra all’altra in ogni fase del gioco.
I l fòcu in Pigrese significa fiammifero e più propriamente zolfanello, ma non ho mai trovato un nesso immediato tra il nome e il gioco. Un’ipotesi che non richiede molta fantasia suggerisce che, in antico, uno zolfanello avesse qualche parte nel gioco, e forse qualche credito a questa ipotesi può essere dato dal fatto che ancora ai miei tempi l’azione che cominciava il gioco si chiamava dà 'l fòcu, che letteralmente significa "dare il fiammifero".
La piazza era, per il fòcu, un campo di gioco quasi ideale perché, includendovi anche il tratto di strada che fiancheggiava la zona in terra battuta, offriva la giusta disponibilità di spazio in relazione al gioco e una conveniente forma di quasi rettangolo non troppo allungato.
Le due squadre, mediamente composte da cinque giocatori ciascuna e formate col solito sistema di scelta alternata dei componenti, si collocavano sui due lati corti del rettangolo, coincidenti con le estremità Est e Ovest della piazza, lungo linee ben definite che agli effetti del gioco si chiamavano "segni".
Il gioco, basato sulla "cattura" degli avversari (vinceva la squadra che faceva prigionieri tutti i componenti dell’altra) aveva poche regole e tanto semplici da applicare quanto -temo- laboriose da spiegare.
lo ci provo.
Le squadre si allineavano sui "segni" dopo che un "pari e dispari" aveva stabilito a quale delle due spettava la scelta del campo e il vantaggio (non rilevante) di ”dare il fòcu" per prima, Chiamiamo A questa squadra e mettiamola sul segno Ovest, chiamiamo B l’altra e mettiamola sul segno Est.
A questo punto conviene enunciare la regola fondamentale del fòcu: può catturare qualunque avversario in azione il giocatore che ha lasciato il segno dopo l’avversario.
l Torniamo alle due squadre allineate sui propri segni. Un giocatore della squadra A (chiamiamolo Al) si avvicina al segno della squadra B, sceglie a sua discrezione un avversario (chiamiamolo Bl) e gli si mette di fronte per ”dargli il fòcu". Per fare questo, A1 deve toccare in un punto qualsiasi B1 (che tiene un piede sul proprio segno Est) contestualmente gridando fòcu! E partendo di scatto verso il proprio segno Ovest. La contromossa di Bl può essere l’affondo in avanti di un braccio o di una gamba per toccare a sua volta Al con una mano o con un piede prima che sia fuori portata, oppure l'immediata rincorsa per raggiungerlo e toccarlo, Tutto questo però può essere preceduto da una serie di mosse 0 gridi fasulli da parte di Al il quale, per esempio, grida fòcu! allungandosi verso B1 ma senza toccarlo, oppure lo tocca ma storpia il grido in fòtu! o altro, mosse e gridi non validi ma che provocano disorientamento in Bl il quale, dopo essere scattato invano, si rimette in guardia magari proprio nell’attimo in cui Al esegue la sequenza valida di toccata e fuga.
Supponiamo ora un’azione valida di Al e una risposta efficace di B1 il quale lo tocca di scatto 0 lo raggiunge e lo tocca dopo pochi passi: A1 è prigioniero e il fòcu passa alla squadra B.
Supponiamo invece che Al non si faccia toccare di scatto e fugga. B1 lo insegue ma se non lo raggiunge prima di metà campo dovrà tornare velocemente verso il proprio segno perche un altro avversario (diciamo A2) gli sarà scattato immediatamente incontro e se lo tocca lo farà prigioniero, avendo lasciato il segno dopo di lui; ma A2 dovrà guardarsi da B2 che sarà scattato dal segno un attimo dopo ed è quindi in vantaggio su di lui, dovendo però guardarsi da A3 che in questo istante e l’ultimo ad aver lasciato il segno..., e così via con partenze e ritorni precipitosi e una situazione generale che potrà essere ulteriormente complicata dal fatto che un A, per esempio, avrà fatto un balzo in avanti dal proprio segno per far partire un B che sarà in vantaggio su di lui, ma immediatamente avrà fatto un balzo indietro per ripartire dal segno in vantaggio su quel B.
Alla fine di questo bailamme un A avrà catturato un B o viceti versa, oppure -sembrerà impossibile- nessuno ha catturato qualcuno e le due squadre sono schierate un’altra volta sui propri segni. Se A ha catturato un B, agli effetti del fòcu la situazione resta immutata, cioè un A andrà a dare il fòcu a un B. Al contrario, se è stato fatto prigioniero un A, il fòcu passerà alla squadra B e sarà quindi un B che darà il fòcu a un A con un’azione identica a quella che ho descritto all’inizio, ciò succederà ogni volta che una fase di gioco si conclude con la cattura di un prigioniero.
Ma supponiamo ora che la fase di gioco si concluda senza alcuna cattura. In questo caso le squadre sono riallineate sui propri segni, il fòcu resta alla squadra che ha fatto un prigioniero per ultima (diciamo A) ma il gioco riprende con un’azione diversa dalle precedenti. Infatti non ci sarà un A che va a dare il fòcu a un B, ma ci sarà un B obbligato da un’altra regola del gioco a lasciare il proprio segno Est e ad avanzare verso Ovest. Farà questo con cautela, tenendosi su un lato lungo del campo e fermandosi a una distanza di relativa sicurezza da Ovest. Subito dopo di lui (e quindi in vantaggio su di lui), un A avrà lasciato il proprio segno e avanzerà verso Est tenendosi sul lato opposto rispetto al B, fermandosi a una distanza di relativa sicurezza da Est e quindi più o meno all’altezza dell’avversario.
A questo punto abbiamo un A e un B che si fronteggiano da due lati opposti del campo di gioco. L'iniziativa spetta a chi può catturare l’altro, cioè ad A. Questi, sempre con un occhio rivolto al segno avversario (Est), farà qualche cauto passo verso B cercando di farlo ”scendere" verso Ovest. Per indurlo a ciò, A dovrà pericolosamente "salire" verso Est ed ecco che ora abbiamo A e B a distanza ravvicinata ed entrambi sbilanciati verso i segni nemici, dai quali tutti gli altri sono pronti a
balzare in avanti.
Per qualche lungo momento tutti sono immobili, come paralizzati dalla tensione, poi A si decide e scatta verso B compiendo un breve arco per chiudergli la via di fuga verso casa. Per sfuggirgli, a B non resta che compiere un arco in senso opposto cosicché i due si aggirano a vicenda e precipitevolissimevolmente rientrano ai propri segni dal lato opposto a quello percorso lasciandoli. Ma intanto, nel momento in cui ciascuno dei due e più vicino al segno nemico, da Est e da Ovest è scattato un loro compagno per catturare l’avversario e poi in rapidissima successione si ripetono scatti e rientri che creano un’indescrivibile baraonda fino a che uno è preso (o nessuno è preso) e si ricomincia. E qui lasciatemi dire che se all’inizia della fase di gioco che ho appena descritto l’A non catturava il B e quindi si verificava il reciproco aggiramento (si chiamava girò! E lasciatemelo tradurre con "girello") l’azione era tale -per preparazione, studio, attacco e difesa- da meritare veramente un applauso.
E i prigionieri? E giunto il momento di occuparcene, anche per i rispettare il precetto evangelico sui carcerati.
l prigionieri fatti dalla squadra A (segno Ovest) formavano una catena a braccia tese allungandosi verso Est sul lato Nord del campo di gioco, mentre la catena dei prigionieri fatti dalla ' squadra B si allungava in posizione opposta e simmetrica da Est verso Ovest lungo il lato Sud. l prigionieri potevano essere liberati soltanto dal compagno che lasciava il segno dopo aver ricevuto il fòcu e che arrivava a toccare il più vicino (e in quell’istante gridava bandèra, bandiera!) senza essere bloccato da un nemico. La catena, ovviamente, diventava più lunga, e quindi relativamente più facile da raggiungere, a ogni prigioniero che si aggiungeva, ma ogni prigioniero aggiunto significava un compagno in meno che poteva collaborare all’azione di liberazione...
Una situazione di particolare interesse si presentava quando le due squadre restavano prima con due giocatori ciascuna e poi con due contro uno. Poniamo due A contro un B. Dopo la cattura del penultimo B, un A deve dare il fòcu all’unico superstite di quella squadra, al quale tuttavia non conviene catturare questo A che infatti gli da il fòcu senza fuggire e standogli di fianco per lasciargli via libera. Perché?
Mi piacerebbe dirvelo alla prossima puntata ma siccome non è prevista sono costretto a dirvelo subito: perché se prende questo A, l’ultimo B sarà poi costretto a dare il fòcu all’ultimo A per il quale sarà fin troppo facile concludere vittoriosamente la partita con la sua cattura, oppure con una volata senza oppositori fino a raggiungere e toccare incontrastato il segno nemico, il che -quinta e ultima regola, valida in ogni fase del gioco- gli dà diritto di fare un prigioniero, che sarà appunto l’ultimo B.
Ma adesso la partita è tutta in mano a questi due: l'ultimo B che sta per ricevere il fòcu a Est e l'A che lo punta da Ovest.
Scatteranno praticamente insieme dai segni: B per liberare i suoi compagni prigionieri, A per catturarlo prima che ci riesca.
Vinca il migliore!
Della complessità del gioco e del multiforme impegno che richiedeva spero di avervi dato almeno un’idea, che penso ora di migliorare aggiungendo che il "bridge" (tanto per citare un gioco per il quale pure si tirano in ballo i punti cardinali) può forse essere paragonato al fòcu per le sottigliezze tattiche, ma lascia più tempo per pensare!
Come dite? Che l’ho fatta troppo lunga? Ma sì, può darsi, tanto che leggerò volentieri qualunque esauriente descrizione del fòcu più breve della mia.
Tratto dal libro di Deo Ceschina
Si ringrazia la moglie Elisa Ceschina per la pubblicazione

Il boeugi (Le buche)
Anche al boeugi si giocava generalmente in piazza, sebbene fosse adatto qualsiasi luogo che avesse il fondo in terra battuta e fosse abbastanza spazioso. Il fondo in terra battuta era necessario per potervi scavare le buche, e lo spazio ci voleva per potersi allontanare di corsa dalle stesse".
Se mi passate l’apparente contraddizione definirò quello delle buche un gioco di gruppo individuale, nel senso che si giocava in tanti ma ognuno per sé contro tutti gli altri. Almeno in teoria, perché poi nella pratica qualche alleanza non dichiarata si poteva stabilire, qualche favore si poteva scambiare. Ma andiamo con ordine.
Occorreva intanto una soda palla di pezza (come quella del Bèes), una per tutti, e occorreva una buca per ogni partecipante al gioco.
Le buche, naturalmente, si facevano sul posto, scavandole con l’aiuto di un legno o di un sasso e rifinendole a mano per compattarne i bordi e le pareti. Ognuno scavava la propria ma tutte dovevano avere la stessa dimensione, che era quella di una scodella di capienza media. Erano disposte per il lungo, in fila indiana, molto vicine una all’altra. Cominciamo.
La prima fase del gioco e di ogni turno successivo consisteva nel far rotolare la palla di pezza, come fosse una boccia, verso le buche, con lo scopo di farla entrare in una di esse. Ogni giocatore, a turno, effettuava questo tiro (da una distanza di circa due metri dalla buca più vicina) mentre tutti gli altri stavano a lato delle buche, chini sulle medesime, ciascuno avendo ben presente qual era la propria.
La palla parte, rotola verso le buche e, a seconda della forza impressa al tiro, si ferma nella prima o nella seconda, oppure le scavalca entrambe e va a fermarsi in una delle successive, magari in quella di chi ha tirato. La palla sta ancora assestandosi in una buca quando il titolare di quella buca scatta a raccoglierla. Tutti gli altri sono già schizzati via, a raggiera, ma lui mira a uno e gli scaglia contro la palla. Se è centrato, il colpito avrà una penalità; se è mancato, la penalità sarà per chi ha tirato. Ma attenzione: il fuggitivo colpito può raccogliere la palla da terra e scagliarla a sua volta verso un altro, e così via, ripetendosi le eventualità che ho detto, fino a quando uno fallirà il bersaglio e la penalità sarà definitivamente assegnata e marcata con l'introduzione di un sassolino nella buca del penalizzato. Credetemi: ho cercato di essere il più conciso possibile ma di sicuro il sassolino è già nella buca mentre io sto ancora scrivendola.
Un altro giocatore farà rotolare la palla cercando di farla andare in una buca (anche perché, se non ci riesce, un sassolino finirà nella sua); ci saranno altre fughe, altri tiri, altri sassolini nelle buche: qui e lì due, là e qua tre, in questa, e magari anche in quella, quattro. E da adesso si fa sul serio, perché il quinto sassolino fa male, come vedremo; e adesso si può fare e ricevere un favore perché chi è di turno a far rotolare la palla può tentare di non farle raggiungere o di farle scavalcare la buca del più amico tra gli amici, specialmente se questa ha già quattro sassolini.
Ma è sicuramente prossimo il momento in cui una buca ne avrà cinque e il titolare di quella buca, avendo perso il primo gioco, dovrà prepararsi a passà 'l mài, a passare il maglio.
Ecco tutti gli altri disporsi su due file di fronte, a braccia alzate, lasciando tra una fila e l’altra soltanto lo spazio per il passaggio del perdente. Ecco costui infilarsi in quello spazio e percorrerlo ingobbito il più velocemente possibile, proteggendosi la testa con le mani mentre un mulinare di braccia gli fa cadere una gragnuola di colpi sul groppone, certo, le pacche sulla schiena si sentono, e dopo il passaggio sotto quelle doppie o triple forche caudine non sarà facile recuperare immediatamente la posizione eretta. Specialmente se qualcuno, trascinato dalla foga da un vecchio risentimento, avrà menato una botta più dura (in questo caso chi l’ha presa la incassa col sano proposito del "buon rendere" e chi l’ha data sa che più prima che poi toccherà a lui).
Pacche che si sentono, dicevo, e che tuttavia non hanno mai costretto nessuno a rinunciare al turno di gioco successivo che, spazzate le buche, ha subito inizio. E nessuno, finito l’ultimo gioco, se ne andrà senza aver piegato un’ultima volta la schiena indolenzita per colmare diligentemente la propria buca.
Tratto dal libro di Deo Ceschina
Si ringrazia la moglie Elisa Ceschina per la pubblicazione
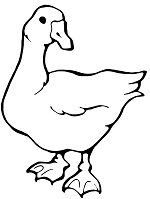 l'Oca
l'Oca
Anche a oca si giocava in piazza. C’era (e c’è ancora, necessariamente ”ristrutturato"), un muretto alto circa un metro e venti che occupa sul lato Nord quasi un terzo della lunghezza della piazza e delimita verso questa uno spazio privato davanti a una casa d’abitazione.
Il muretto, che dal lato prospiciente la casa è alto una quarantina di centimetri ed è in pratica una lunga panchina col sedile allora in sasso e adesso in cemento, pareva messo lì apposta perché noi potessimo giocare a Oca (un gioco -come state per apprendere- che era quanto di più lontano si possa immaginare dal diffusissimo ”gioco dell’oca").
Formate le due squadre e stabilito, nei modi consueti, quale doveva star "sotto” (e nel caso dell’oca "stare sotto" significava davvero essere sotto), uno dei componenti di quest’ultima (chiamiamola squadra A) appoggiava le braccia, ripiegate, sulla sommità del muretto e poi, piegato in due, si stendeva verso la piazza. Un suo compagno si incurvava su di lui afferrandolo alle reni e mettendo la testa sotto un braccio, un terzo si piegava allo stesso modo sul secondo, sempre cercando di riparare la testa con un braccio, e cosi via fino all’ultimo. Alla fine si aveva un fila di cinque o sei ragazzi , curvi e abbracciati uno all’altro, che dal muretto si stendeva ad angolo retto verso la piazza.
A questo punto il primo dell’altra squadra (chiamiamola squadra B), quello che sapeva spiccare il balzo più lungo, prendeva la rincorsa e arrivato a ridosso della schiena dell’ultimo della fila di A vi appoggiava le mani di slancio per un balzo che lo portava a ricadere, se era veramente bravo, sulla groppa del primo della fila. Un suo compagno lo imitava cercando di regolare il balzo per ricadere sul secondo della fila, e cosi via fino all’ultimo della squadra B il quale -in teoria- con un saltino montava in groppa all’ultimo della squadra A.
Facile? A dirsi!
Intanto la prima regola del gioco imponeva a chi saltava che come ricadeva così doveva restare. Se arrivavi sbilanciato a destra o a sinistra potevi si aggrapparti e stare aggrappato a chi avevi sotto, ma non dovevi fare alcun movimento per migliorare la tua posizione (e naturalmente era tassativamente proibito a quelli sotto di fare alcun movimento che la rendesse più critica). Poi non era detto che il primo B che saltava (chiamiamolo B1) arrivasse fino alla groppa di A1. Magari non ce la faceva, oppure il timore di battere con troppa violenza le ginocchia contro il muretto lo induceva a ”frenare" un poco il balzo e se cadeva dove finiva A] e cominciava A2 lì doveva restare, riducendo lo spazio disponibile per i suoi compagni. E così per B2 era indispensabile arrivargli proprio a ridosso e magari stendersi un po' sopra di lui per non ridurre ulteriormente quello spazio. Insomma, a ogni B che saltava la situazione poteva farsi più difficile per la squadra, anche perché c’è sempre da ricordare che spesso si atterrava in una posizione di equilibrio precario che non si poteva correggere. Ecco perchè l’impegno che più frequentemente toccava all’ultimo B (e per questo si lasciava per ultimo quello che sapeva spiccare il balzo più alto) era di saltare in groppa a uno dei suoi. Alla fine, osservando di lato il complesso di quelli sotto e quelli sopra, invece della linea continua e regolare di un ”cavaliere" per ogni ”cavalcatura" era più facile vedere un profilo che ricordava le due gobbe di un cammello o la gobba unica di un dromedario.
Ho accennato alla possibile situazione critica della squadra B i cui componenti, aggrappati fra di loro, aggrappati a quelli della squadra A e talvolta appesi di traverso come bisacce, fanno sforzi tremendi per non ”cadere di sella", ma è facile immaginare che nemmeno i componenti di A hanno vita I comoda: qualcuno di loro sta magari reggendo da qualche minuto un peso doppio del proprio perchè su di lui gravano due B; qualcun altro deve resistere contemporaneamente a un peso sulla groppa e a quello di un B che aggrappato a lui e sorretto per quanto possibile da un compagno gli sta gradatamente scivolando sotto, ma ancora non molla, fin quasi ad assumere la posizione dei compagni di Ulisse sotto le pecore di Polifemo.
A questo punto avete già capito che lo scopo di quelli sopra è di restare comunque "in sella" fino a quando quelli sotto non ce la fanno più a reggerli, e lo scopo di quelli sotto è di resistere fino a quando uno di quelli sopra mette un piede (o qualunque altra parte del corpo!) a terra: nel primo caso al prossimo turno resta sotto la squadra A, nel secondo va "sotto” la squadra B.
Ma, e oca? Era il grido lanciato o il gemito emesso da quello della squadra sotto che per primo cedeva. Ma perchè oca? Non si sa. Forse perchè non si poteva confondere con altri richiami, i forse perchè era più breve e meno esplicito di "mi arrendo"...
Scegliete voi.
Anche se non comportava botte intenzionali agli avversari, dire che oca non era un gioco rude sarebbe negare l’evidenza, e alla fine qualche ammaccatura era inevitabile. Però nessuno si è mai fatto male seriamente e in conclusione le vere ”vittime" erano le mamme, un’altra volta alle prese con tasche penzolanti e asole vedove.
Al pòrtach dal Sìlu. : ll portico del Silu, com’era: un angolo bellissimo. È stato inevitabilmente cambiato, ma con rispetto, tanto che è bello ancora.
Tratto dal libro di Deo Ceschina
Si ringrazia la moglie Elisa Ceschina per la pubblicazione
 I tòr (I tori)
I tòr (I tori)
Il gioco dei "tori" si faceva in piazza. Quale piazza? La piazza.
A Milano quando si dice "in Galleria” nessuno chiede quale galleria!
La pavimentazione della piazza era in terra battuta (ideale per molti giochi) ma lungo tutto il suo lato nord passava (e passa) la strada principale del paese, che allora aveva il fondo di ciottoli e in quel tratto divideva la piazza dalle case.
Il gioco contrapponeva due squadre che in origine si chiamavano rispettivamente Tòr (Tori) e Pnstùu (Pastori). l Tori avevano facoltà di "incornare" i Pastori ai fianchi con zuccate alle quali i Pastori opponevano i gomiti, ma questa pratica non era molto seguita perché agli effetti del risultato della partita poteva essere controproducente per i Tori. Anche per questo il gioco fini col chiamarsi semplicemente i Tòr e col contrapporre due squadre di Tori.
Le squadre si formavano col solito sistema di scelta alternata dei componenti da parte dei due più quotati per quel tipo di gioco e che avevano fatto a "pari e dispari". Se era presente, uno dei due era inevitabilmente il Zipìn dal Togn che aveva veramente la struttura e la forza di un torello e che spesso risultava determinante per la vittoria della squadra cui apparteneva.
Le regole del gioco erano semplicissime. Una squadra si schierava tutta sull’acciottolato e l’altra la fronteggiava sulla terra battuta (una linea continua di pietre interrate con l’acciottolato segnava visibilmente il confine tra le due zone). Al ”pronti, via!" tutti i componenti di una squadra, tenendosi in qualche modo uniti tra loro, si buttavano su quelli dell’altra afferrandoli il più saldamente possibile in qualunque parte del corpo (ricordate il “prendi come puoi" della lotta libera?) e cercando di trascinarli tutti sul proprio terreno, così vincendo la partita.
Insomma, era una specie di tiro alla fune senza la fune in cui immediatamente le due squadre trasformavano lo schieramento iniziale in un groviglio inestricabile, fondendosi in mischie che non avevano nulla da invidiare a quelle del "rugby".
D’accordo, era sopra tutto un gioco di forza, ma non solo di forza: perché oltre che ”tirare" si poteva anche "spingere" dopo aver aggirato gli avversari (senza mai staccarsi dal gruppo per non indebolire la propria squadra: ecco un motivo per cui si rinunciava a ”incornare”); perché occorreva cogliere gli avversari nei loro momenti critici; perché si doveva magari fingere un cedimento che preludeva invece allo strattone finale che portava tutti i tori dell’acciottolato sulla terra battuta, o viceversa.
Il gioco aveva fasi alterne di predominio dell’una o dell’altra squadra e il risultato restava in bilico finché anche uno solo dei componenti di una squadra teneva un piede sul proprio terreno, mentre tutti i suoi compagni stavano ormai combattendo in campo avverso. Quando anche quell’uno cedeva la partita finiva e se ne cominciava un’altra semplicemente invertendo le posizioni di partenza.
Ora vinceva una squadra, ora l’altra. Il gioco era violento ma non cattivo né pericoloso: alla fine si contavano "feriti" soltanto fra gli indumenti e gli unici ”morti" che restavano sul terreno erano i bottoni!
Tratto dal libro di Deo Ceschina
Si ringrazia la moglie Elisa Ceschina per la pubblicazione
La finta
La finta era un gioco di uno (quello che era "sotto") contro tutti gli altri, sebbene gli altri fossero uniti soltanto dal fatto di trovarsi contro quell’uno.
 Era anche un gioco che richiedeva un minimo di "attrezzatura": un barattolo di latta (uno solo per tutti) e una pietra piatta (una piccola pioeuda) per ciascuno. Trovare una pietra piatta per ciascuno era infinitamente più facile che trovare un solo barattolo per tutti, perché a quei tempi in questi luoghi ne circolavano ben pochi e, di quei pochi, molti erano trattenuti nelle case per utilizzarli, dopo averne consumato il contenuto, come recipienti per usi vari e anche per farne tulìn. Il barattolo, che noi chiamavamo scàtula (scatola), veniva collocato al centro di una riga (la riga della scatola) tracciata a un cinque metri da quella che chiamerò la "riga di lancio".
Era anche un gioco che richiedeva un minimo di "attrezzatura": un barattolo di latta (uno solo per tutti) e una pietra piatta (una piccola pioeuda) per ciascuno. Trovare una pietra piatta per ciascuno era infinitamente più facile che trovare un solo barattolo per tutti, perché a quei tempi in questi luoghi ne circolavano ben pochi e, di quei pochi, molti erano trattenuti nelle case per utilizzarli, dopo averne consumato il contenuto, come recipienti per usi vari e anche per farne tulìn. Il barattolo, che noi chiamavamo scàtula (scatola), veniva collocato al centro di una riga (la riga della scatola) tracciata a un cinque metri da quella che chiamerò la "riga di lancio".
Stando al di qua di questa riga i partecipanti al gioco lanciavano a turno la propria pietra cercando di abbattere la scatola, che naturalmente era stata collocata in posizione verticale.
Alcuni la colpivano al primo tiro ed erano già sicuri di non stare "sotto" se almeno uno degli altri l’avesse mancata; gli altri ci riprovavano, sempre in minor numero, fino a quando uno solo falliva il bersaglio. Se tutti centravano il bersaglio al primo tiro si cominciava da capo, e così anche nei tiri successivi. Alla fine stava giustamente "sotto" chi aveva sbagliato più volte.
A quel punto chi era "sotto" si metteva vicino alla scatola mentre tutti gli altri, dopo che ciascuno aveva ricuperato la propria pietra, tornavano alla riga di lancio per cominciare il gioco, il quale consisteva essenzialmente nel tirare alla scatola e poi, indipendentemente dall’averla colpita o mancata, nell’andare a recuperare una pietra (non necessariamente la propria) senza farsi "prendere" da chi era sotto, per tornare a tirare.
La finta aveva le seguenti regole:
-
Chi è sotto può “prendere”, toccandolo, qualunque altro giocatore soltanto quando la scatola è ritta al suo posto e il giocatore è al di la della riga della scatola;
-
Il giocatore “preso” va sotto al posto cli chi lo prende;
-
Chi è al di là della riga e si impossessa di una pietra ma non ce la fa a rientrare, può lanciarla a chi non ha ancora superato la riga della scatola e questi può tirare di nuovo;
-
Si può tirare alla scatola soltanto dalla riga di lancio;
-
Il tiratore non deve superare col piede la riga di lancio (come i discoboli, i pesisti e i lanciatori di martello e di giavellotto nelle gare di atletica leggera), altrimenti prende il posto cli chi è sotto.
Con queste premesse, vediamo ora al tiro il primo giocatore, che può naturalmente centrare o fallire il bersaglio. Se lo centra, la scatola vola via e il giocatore ha buone probabilità di superare di corsa la linea della scatola prima che chi è sotto abbia rimesso al posto la scatola stessa. (Difficilmente il primo tiratore potrà recuperare immediatamente la pietra e tornare in salvo al di qua della linea della scatola, perché nell’andata deve percorrere anche i cinque metri che separano questa linea dalla linea di lancio).
Se invece manca il bersaglio, gli converrà aspettare un’altra i fase del gioco per passare al di là della riga della scatola. Nota: chi ha tirato ed è rimasto al di qua della linea può avvicinarsi alla stessa in attesa del momento buono per superarla.
Un’altra fase può essere il tiro del secondo giocatore dopo il quale, a seconda che la scatola sia stata abbattuta o sia rimasta in piedi, avremo uno o due giocatori che passano correndo oltre la sua linea o che aspettano il tiro del terzo giocatore, e cosi via.
Nota: chi ha superato quella linea ed è braccato da chi è sotto può fuggire anche nella direzione opposta a quella del rientro.
Una situazione tipica del gioco, che può presentarsi sia dopo la prima serie di lanci che in ogni fase successiva, è quella in cui tutti hanno tirato; alcuni sono al di là della linea della scatola e cercano di rientrare con la pietra; altri sono rimasti al di qua ma si tengono vicinissimi alla linea, pronti per oltrepassarla; la scatola è ritta al suo posto e chi è sotto può prendere chiunque sia in movimento al di là della linea. (Intanto tutte le pietre sono al di la della linea, più o meno lontane dalla stessa e tra
loro anche nel senso della larghezza del campo perché i tiri sono stati fatti da angolazioni diverse per disseminare le pietre su un’area più vasta e rendere più difficile il controllo del campo da parte di chi è sotto).
A questo punto cominciano le finte che danno il nome al gioco.
Chi è al di qua della linea può fingere uno scatto verso la stessa per attirare su di sé attenzione di chi è sotto e consentire un rientro o almeno il rilancio di una pietra al di qua della linea. Ugualmente chi è al di là della linea può fare la finta di partire per il rientro favorendo gli scatti di altri per veloci passaggi della linea nei due sensi, mentre chi è sotto cercherà di prendere qualcuno prima che quelli che sono riusciti a tornare alla linea di lancio abbattano la scatola, magari uno dietro l’altro, costringendolo a ripetuti recuperi e riposizionamenti della stessa mentre gli turbinano intorno quelli che vanno e quelli che vengono...
Certamente la posizione di chi è "sotto" è ingrata in tutti i giochi, ma il meccanismo del gioco della finta la rendeva particolarmente dura e spesso anche di lunga durata (i più coraggiosi rischiavano botte alle caviglie per fermare o almeno rallentare con un piede, per averle più vicine, le pietre tirate dalla riga di lancio), Prima o poi però uno ce la faceva a "beccare" chi l’avrebbe sostituito e allora il gioco diventava bello anche per lui.
Finito il gioco, a un compagno fidato si dava l’incarico di custodire la scatola, per ammaccata che fosse, ché la prossima volta non si dovesse tribolare come stavolta per trovarne una.
PS. Per questo gioco, domandando come per tutti gli altri spiegazioni o conferme, ho trovato due versioni diverse tra loro e discordi dalla mia su come si stabiliva chi doveva "stare sotto". Secondo una versione si faceva semplicemente una conta, secondo l’altra tutti lanciavano la pietra verso la scatola per andarvi il più vicino possibile e stava sotto chi ne restava più lontano. Ho mantenuto la mia (che avete letto all’inizio e che non è soltanto mia) perché mi pare più pertinente al gioco.
Ma credetemi: lascerei volentieri ai posteri l’ardua sentenza, se io stesso non fossi un postero!
Tratto dal libro “d'ind'èi d'indè” di Deo Ceschina - Si ringrazia la moglie Elisa per la pubblicazione.
 Al bèes
Al bèes
Il bèes era un gioco praticato indifferentemente da squadre di ragazzi, da squadre di ragazze e da squadre miste di ragazzi e di ragazze. In ogni caso le squadre contrapposte si formavano con l’equo sistema della scelta alternata dei compagni da parte di due partecipanti già predestinati in campi avversi e che in genere erano poi nominati "capitani" delle rispettive squadre.
Un secondo "pari e dispari" tra i due determinava quale squadra avrebbe giocato la prima partita "in casa", cioè nella posizione di gioco più ambita.
A questo punto si stabiliva la dislocazione dei "cantoni", il cui numero doveva essere uguale al numero dei componenti di una squadra, meno uno. Le loro posizioni erano invece scelte in relazione all’ampiezza e alla conformazione del campo di gioco, ma erano sempre tali da comportare, nel loro succedersi, un percorso che iniziava allontanandosi dalla "casa" e dopo un inevitabile attraversamento del campo si concludeva in senso inverso, cioè avvicinandosi alla "casa".
La posizione dei cantoni, quando non era marcata da un riferimento fisso (per esempio il punto di scarico di un canale di gronda, o un paracarro, o una sporgenza del muro) veniva segnata a terra con una grossa pietra. Stabiliti i cantoni poteva cominciare la partita, per la quale bisognava disporre di una palla di pezza, ben soda e grossa più o meno come una palla da tennis.
La squadra “in casa”, i cui componenti entravano in gioco uno alla volta, stava a una estremità del campo di gioco mentre l’altra squadra si disponeva in ordine sparso ma non casuale sul campo, dal primo cantone in poi fino alla distanza massima cui si presumeva potesse arrivare la palla lanciata dai giocatori della squadra in casa. Il lancio veniva fatto come si fa nel "servizio" del gioco del tennis ma usando, per colpire la palla, il palmo della mano invece della racchetta. Cominciamo.
Il primo giocatore della squadra in casa lancia la palla, cercando di mandarla il più lontano possibile o in una zona meno "coperta" dagli avversari, e immediatamente dopo il lancio parte di corsa verso il primo cantone. A questo punto si presentano due possibilità:
-
La palla viene presa ”al volo" da un avversario. In questo caso il lanciatore è ”morto", torna in casa e per il momento è fuori dal gioco. (Nota: il lanciatore era comunque "morto" se non buttava la palla oltre il primo cantone),
-
La palla non viene afferrata al volo e finisce a terra. In questo caso il lanciatore raggiunge il primo cantone e vi si ferma, in salvo; oppure, dopo aver "toccato" il primo cantone, prosegue verso il cantone successivo. Ma attenzione: nel frattempo un avversario avrà raccolto la palla da terra e sarà pronto a tirargliela contro: se lo colpisce sul percorso tra un cantone e l’altro lo fa ”morto" e lo rimanda in casa. Se invece il lanciatore si è fermato in salvo al primo cantone (o a un cantone successivo dopo aver manifestamente "toccato" i precedenti) la palla viene resa alla squadra in casa.
Quando il secondo giocatore della squadra in casa lancia la palla, tutto si ripete: con la differenza che (se la palla non viene presa al volo da un avversario), mentre il secondo lanciatore corre verso il primo cantone il compagno che l’ha preceduto corre verso il secondo o verso il terzo o comunque, sempre rispettando l’ordine di successione dei cantoni, verso quello che presume di poter raggiungere in salvo. Nota bene: accettando il maggior rischio di essere colpito durante il tragitto, il
primo lanciatore può correre verso un cantone successivo anche se la palla del secondo lanciatore è presa al volo.
La partita prosegue con i lanci di tutti gli altri giocatori della squadra in casa, ogni volta aumentando il numero di chi corre verso cantoni successivi e quindi ogni volta aumentando le possibilità degli avversari di colpirne qualcuno con la palla durante il percorso, rinviandolo in casa “morto" e quindi temporaneamente fuori dal gioco.
Ma intanto, cantone dopo cantone, il più avanzato fra i giocatori della squadra in casa sarà arrivato all’ultimo e se -dopo avervi sostato o anche soltanto dopo averlo toccato- ce la farà a rientrare in casa potrà ricominciare a lanciare la palla, subito o dopo altri compagni, secondo la situazione della squadra.
Abbiamo fin qui considerato il caso del giocatore che non si è fatto prendere la palla al volo e che è riuscito a tornare in casa avendo toccato tutti i cantoni senza farsi colpire con la palla dagli avversari. Ma cosa succede quando un giocatore è rinviato a casa ”morto" e temporaneamente fuori dal gioco?
Succede che entra in scena il capitano. Il quale deve ora dimostrare di meritare la sua qualifica, cioè di essere quello, fra i suoi, che sa dare alla palla di pezza la "pacca" (la pèca) più forte e più precisa.
Il capitano parte ogni volta che uno dei suoi torna a casa "morto". A ogni partenza ha a disposizione tre lanci (ecco i privilegi del grado!) e quindi può "morire" due volte prima di essere spacciato definitivamente per palla presa al volo (ma sarà fatto secco al primo colpo se viene centrato durante il percorso), Dopo il primo lancio valido, se è un buon capitano arriverà indenne almeno fino al secondo cantone; poi dovrà farsi il suo bravo giro scattando a ogni lancio dei suoi, per rientrare incolume in casa. Se ci riesce farà tornare “vivo” uno dei suoi che era "morto”, rimettendolo in gioco, e magari dovrà ripartire immediatamente per un altro recupero, ma a ogni suo rientro ci sarà un "morto" che... resuscita, e quindi altri lanci, altre corse, altri ”morti" e altre "resurrezioni” fino a quando il capitano stesso cadrà sul campo, Allora la sua squadra avrà perso la partita e dovrà giocare la prossima ”fuori casa".
Il bèes, non semplicissimo da spiegare e non semplice da giocare, richiedeva alla squadra in casa potenza e precisione nel lancio della palla e velocità sul percorso tra i cantoni, e richiedeva all’altra squadra agilità nell’afferrare la palla al volo o nel raccoglierla da terra e prontezza e precisione di tiro per colpire con la palla (che poteva anche essere passata a un compagno in posizione più favorevole) l'avversario in corsa.
 Non era ammesso che più d’un giocatore della squadra di casa fosse fermo al medesimo cantone, e anche per questo il gioco aveva fasi di grande concitazione quando più numerosi erano i giocatori sul percorso tra i cantoni e quindi più numerosi erano, per gli avversari, i possibili bersagli.
Non era ammesso che più d’un giocatore della squadra di casa fosse fermo al medesimo cantone, e anche per questo il gioco aveva fasi di grande concitazione quando più numerosi erano i giocatori sul percorso tra i cantoni e quindi più numerosi erano, per gli avversari, i possibili bersagli.
Chi ha un minimo di conoscenza del ”baseball" ha certamente rilevato come questo gioco, ormai diffuso in tutto il mondo, abbia spiccate analogie, a partire dal nome, col bèes che si giocava a Pigra.
Come? Avrei dovuto dire che era il nostro bèes ad assomigliare al "baseball"? D’accordo, d’accordo! Dopo tutto, che differenza fa?
Tratto dal libro “d'ind'èi d'indè” di Deo Ceschina - Si ringrazia la moglie Elisa per la pubblicazione.

Burghént e Burghenton sono i nomi di due "pozze" (che voi potete anche chiamare "vasche naturali") create come tante altre in diversi punti del proprio letto dal torrente che scorre nella valle del Mulino. Questa valle, che per buona parte della sua lunghezza segna il confine tra il territorio di Pigra e quello di Colonno e quindi divide la Val d’Intelvi dalla Tremezzina, al suo sbocco nel Lago di Como si chiama Val di Camoeugi. I Pigresi pero l’hanno sempre chiamata e continuano a chiamarla Valle del Mulino perché sulla sua riva destra, e quindi in territorio di Pigra, giravano un tempo (più o meno fino a cent’anni fa) le ruote a pale di due mulini, di cui restano ancora poche tracce.
Nella Valle del Mulino affluiscono tutti i torrenti che scorrono a est di Pigra, cioè al Quai dal Busan, al Quai di Cugnoo, al Quai dala Neef e altri minori, alcuni confluendo tra loro prima di raggiungerla, Vi confluiscono anche il Quai da Màlach e il Quai da Frécia, due dei tre torrentelli che attraversano l’abitato. (All’uscita dal paese il Quai da Frécia diventa Quai da Riif e poi, molto più a valle, Quai da Guss). Il terzo era il Quai da l’Era, che si perdeva nel terreno poco sotto il paese, Nei tempi di cui parlo tutte tre erano scoperti per quasi tutto il loro corso anche nell’attraversamento dell’abitato: come, nello stesso periodo, i navigli di Milano... In alto del paese, in un tratto relativamente pianeggiante, il Quai da Frécia formava un paio di piccole pozze in cui le donne di quel "cantone" andavano a lavare i panni nell’acqua fredda e limpida, sempre ché appena più a monte non ci fossero bambini o ragazzi che la intorbidivano con i loro giochi.
Torniamo nella Valle del Mulino. Seguitando il discorso di carattere idrogeografico che mi sta severamente impegnando, vi dir che quelle pozze (voi continuate pure a chiamarle vasche naturali) di cui parlavo all’inizio si fermano naturalmente ai piedi delle cascatelle frequenti lungo il corso dei torrenti di montagna: più alta e ripida è la cascata (ma nei punti agibili del torrente si tratta al massimo di un paio di metri), più profonda è la pozza ai suoi piedi (e siamo ancora, al massimo, sui due metri). Poi la pozza, che è larga quanto è largo il letto del torrente in quel punto ed è incassata fra le rocce, diminuisce gradatamente di profondità fine a sfociare, in pochi metri, al livello a cui il torrente scorre, per un certo tratto, quasi orizzontale.
Bene, nel Burghént e nel Burghenton (c’era anche un Burghintìn, come c’erano un Salàm e un Padelòt, ma erano pozze piccole), noi ragazzi di Pigra andavamo, d’estate, a fare il bagno. Ma dov’è il gioco?, si dirà. Beh, se il gioco è divertimento, fare il bagno in quelle pozze era un divertimento e quindi era un gioco.
Partivamo da Piazza S. Rocco, al centro del paese, subito dopo il pasto di mezzogiorno (vale a dire non oltre le 12,30) e facevamo di corsa, e a salti, la strada tutta in discesa che porta alla Valle del Mulino. Facevamo a chi arrivava prima, e nel giro di una dozzina di minuti il più veloce si toglieva di dosso il sudore della corsa tuffandosi nel Burghént.
Ignoro vergognosamente la temperatura dell’acqua dei torrenti di montagna, ma se vi dico che e fredda potete credermi. Potete credermi anche se vi dico che a nessuna di noi piccoli incoscienti e mai capitato il minimo inconveniente per non aver rispettato le sagge regole di non bagnarsi se si è accaldati e con la digestione in corso.
Dopo il bagno ci si sdraiava a pancia in giù sui grandi massi disseminati lungo il letto e il greto del torrente per farsi asciugare, di sotto, dal calore del sasso, e di sopra dal calore del sole. La sensazione era così piacevole, e così piacevole era il tuffarsi nell’acqua limpida, che il bagnarsi e l'asciugarsi erano ripetuti più volte nel corso del pomeriggio.
Tra un bagno e l’altro i più piccoli immettevano, a monte, in qualche rivoletto che nei tratti pianeggianti sempre accompagna ai lati il flusso principale, dei legnetti che la corrente trasportava. Ciascuno aveva scelto accuratamente il proprio con la convinzione che sarebbe sceso più veloce degli altri arrivando per primo al traguardo prefissato più a valle. Lungo il percorso i legnetti erano allegramente incitati, fino al grido d’esultanza del vincitore. Quei legnetti erano le nostre ”macchinine".
Il Burghenton, un bel po' più a valle, era una pozza molto più grande e profonda del Burghènt. Le sue pareti erano coperte di muschio e l’acqua vi era più fredda perché la pozza era affiancata da una fitta vegetazione che la nascondeva al sole e chiudendosi a cupola sopra di essa la teneva in una penombra quasi misteriosa, In compenso, per i riflessi del muschio e delle fronde, era di una indicibile limpidezza verde.
Certo i bagni più comodi si facevano nel sarai, le rare volte in cui concorrevano le circostanze che consentivano di riempire con l'acqua del torrente la grande vasca superstite del Mulìn dal Tata. (Una di quelle indispensabili circostanze era la temporanea assenza, nei cascinali sul fianco opposto della valle, dei ragazzi che salivano da Colonno negli alpeggi estivi di quel paesotto lacustre. Per una rivalità che si perde nella notte dei tempi e per la quale non era pensabile, per esempio, che Pigresi e Colonnesi potessero fare il bagno insieme nella Valle del Mulino, quei ragazzi distruggevano di sera il canaletto che noi avevamo ripristinato di giorno per fare affluire acqua dal torrente alla vasca).
Il sarai del Mulìn dal Tata, ricavato in posizione sopraelevata sul fianco della valle, era vicino al Burghènt, aveva forma tondeggiante, un diametro medio di otto o nove metri, una profondità massima di oltre due metri, Bene esposta al sole, che vi intiepidiva l’acqua, nei giorni fortunati la vasca era frequentata come una piscina di città.
Sempre piena invece era la vasca del Mulìn dal Mulinée, sopravvissuta in buone condizioni al mulino. Era molto più a monte e si raggiungeva, dal paese, percorrendo altre strade e altri sentieri. Più piccola dell'altra come superficie ma molto più profonda (almeno tre metri), non era riempita dal torrente che le scorreva a lato ma da acqua sorgiva che sgorgava, visibile, da una roccia soprastante.
Ignoro anche la temperatura alla fonte dell’acqua sorgiva, ma se mi avete concesso che l’acqua di torrente sia fredda potete tranquillamente concedermi che quella di sorgente sia ”gelata". Se, col presupposto di fare il bagno in quell’acqua, la "saggiavi” con la punta di un dito, tornavi a casa. C’era un solo modo di entrarvi: pensare ad altro e buttarcisi. lo ci sono entrato una volta, perché anche quella era una prova da superare,
Non trovo una situazione pratica da citare come termine di confronto per descrivere la sensazione di quell’impatto, ma avete presenti i personaggi dei cartoni animati quando vengono folgorati dalla corrente elettrica? Ecco, una cosa cosi. Poi le risorse dell’età e il dio dei ragazzi e degli incoscienti ti scioglievano dalla paralisi e ti accompagnavano a riva.
Per finire, voglio dedicare due righe anche al Quai di ciap, il torrente delle rocce, lungo il quale spesso ci si inerpicava ritornando dal Mulìn dal Tata. Quasi sempre asciutto, aveva alcune belle paretine ripide da scalare in arrampicata libera, salendo di quota fino alla Strada da Loeumia che poi ci portava a casa, pronti per domani.
Tratto dal libro “d'ind'èi d'indè” di Deo Ceschina - Si ringrazia la moglie Elisa per la pubblicazione.
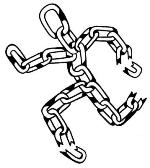 Tra i giochi che contrapponevano due squadre era uno dei preferiti, forse perché consentiva di sfogare in lunghe corse, come inseguito o come inseguitore, l’esuberanza dell’età.
Tra i giochi che contrapponevano due squadre era uno dei preferiti, forse perché consentiva di sfogare in lunghe corse, come inseguito o come inseguitore, l’esuberanza dell’età.
Aveva regole molto semplici, a cominciare dalla formazione delle squadre.
Il vincitore di un "pari e dispari" fra i due ragazzi che godevano di maggior considerazione da parte di tutti in relazione al gioco (e che automaticamente non avrebbero fatto parte della stessa squadra) sceglieva il suo primo compagno. L'altro sceglieva a sua volta il primo dei suoi, e così via, alternativamente. Naturalmente ciascuno dei due sceglieva quello che considerava il migliore fra i rimasti, e così alla fine le due squadre erano sempre abbastanza equilibrate. Il numero dei componenti di ogni squadra variava in funzione del numero dei presenti, e se questo era dispari, pazienza: una squadra avrebbe avuto un componente in più (per la natura e le regole del gioco, da un certo numero in poi non era quel1'uno in più o in meno a “fare la differenza"). Le ragazze non erano escluse da questo gioco, e ce n’erano alcune (ricordo in particolare la Tina dal Peulìn) alle quali era difficile tenere testa nella corsa.
Formate le squadre, ci si accordava sulle dimensioni del campo di gioco stabilendone i confini nelle quattro direzioni: i su, i gio', i dènt, ì foeura in relazione alla base da cui si partiva che era sempre gio' l’usc dala Mìrina, un punto molto vicino al centro del paese e nel quale confluivano e confluiscono tutt’ora, tra grandi e piccole, ben sette strade.
L'ampiezza del campo di gioco era solitamente rapportata al numero dei componenti delle squadre e se questo numero era particolarmente elevato si decideva che il campo di gioco fosse tut al paìs, tutto il paese, cioè un cerchio ideale tanto grande da includere anche le case più lontane.
Dopo questa decisione, un altro "pari e dispari" stabiliva qual era, per il primo turno di gioco, la squadra dei lìbar (liberi) e quale quella dei maghi (Maghi), cioè quella di chi si sarebbe sparpagliato per il paese per nascondersi negli anfratti più impensati (i tan, le tane) e quella di chi avrebbe dovuto, appunto, stanarli e farli prigionieri.
Ciò fatto i liberi partivano, soli o a coppie, verso il nascondiglio da ciascuno già mentalmente prescelto e i maghi restavano alla base in attesa che uno dei liberi, precedentemente incaricato dai compagni, lanciasse da lontano il grido antico, aruz! che segnava l’inizio del gioco.
Immediatamente i maghi si sguinzagliavano alla ricerca e dopo due o tre minuti cominciava per le vie del paese un carosello di coppie composte da un libero stanato e da un mago che lo inseguiva fino a raggiungerlo (per farlo prigioniero doveva toccarlo) se l'inseguito non lo distanziava tanto da fargli perdere le sue tracce. (capitava naturalrne11te che i percorsi delle coppie si intersecassero e che un libero finisse nelle grinfie di un mago che stava inseguendone un altro, oppure che tra due coppie che si incrociavano gli inseguitori si scambiassero gli inseguiti avendo calcolato istantaneamente (cioè con la velocità dei "computer" che non c’erano ancora) le maggiori probabilità di successo.
Ogni libero catturato veniva accompagnato alla base dove si aggiungeva ad altri eventualmente catturati prima di lui e con essi formava, tenendosi per le mani a braccia distese, una "catena" che pur dovendo mantenere almeno l’anello centrale con la schiena appoggiata al muro si allungava quanto più poteva verso questa o quella delle sette strade da cui poteva sopraggiungere un "liberatore" richiamato dal grido di quando in quando lanciato dai prigionieri: Vigniiii a liberà!,
venite a liberare! Naturalmente uno dei maghi era sempre lasciato di guardia ai prigionieri col compito di catturare il loro compagno che veniva per liberarli, toccandolo prima che quello toccasse la ”catena": un compito che diventava sempre più arduo man mano che la catena si allungava oppure quando capitava che i possibili liberatori arrivassero in due contemporaneamente e
da opposte direzioni.
In compenso, la catena lunga significava meno liberi in circolazione e maggior controllo del territorio da parte dei maghi, in una somma di vantaggi e svantaggi che poteva concludersi
con la liberazione dei prigionieri (Lìbar!, era il grido trionfale del salvatore) i quali tornavano velocissimi alla macchia, oppure con la cattura dell’ultimo libero. Nel primo caso il gioco riprendeva con le squadre nello stesso ruolo del turno precedente; nel secondo caso i "maghi" diventavano "liberi" e viceversa.
A Pigra non ho mai visto nessuno a piedi nudi; ho invece più volte visto ragazzi e ragazze che avevano, cucito sotto la suola delle calze di lana grezza, uno spesso strato di pezze che consentivano sia la corsa veloce che un passo che più "felpato" non si poteva immaginare.
Era con questo passo che l’audace liberatore si avvicinava alla base, ma dire della sua fremente circospezione, e per contro della spasmodica attenzione con la quale il guardiano dei prigionieri controllava le sette possibili provenienze; dire i sommessi richiami o i silenziosi cenni d’intesa fra compagni con i quali ciascuna squadra cercava di sopraffare l’altra; dire insomma tutte le astuzie messe in atto per vincere la partita vorrebbe altra tastiera che la mia.
A maghi e lìbar si giocava d'estate, generalmente la sera dopo cena, e a un certo punto bisognava smettere perché s'era fatto tardi o s’era fatto buio e le poche lampade a incandescenza che
costituivano allora l’illuminazione pubblica rischiaravano decentemente soltanto il piatto di ferro verniciato sotto il quale erano avvitate.
Capitava che il momento di smettere arrivasse mentre era in corso un turno di gioco, con una parte di liberi e di maghi ancora in giro per il paese, Allora quelli delle due squadre che si ritrovavano alla base e concordavano la cessazione del gioco gridavano, in coro, ripetutamente, A tèra ’l gìuch!, a tèra ’l giuch! per comunicarne la fine agli altri. Il grido era ripreso dai ragazzi che si trovavano a portata di voce, ciascuno dei quali lo ripeteva a beneficio dei più lontani, e in breve tutti si ritrovavano alla base.
Maghi e lìbar era un gioco in cui ogni partecipante poteva ben figurare per doti di velocità, o di destrezza, o di tempismo; ed era un gioco leale: nessuno dei maghi chiedeva o si aspettava
"soffiate" da estranei al gioco e nessuno dei liberi è mai stato scoperto nascosto in una casa o in altro luogo chiuso, anche perché sarebbe stato squalificato per tutta la stagione!
Tratto dal libro di Deo Ceschina
Si ringrazia la moglie Elisa Ceschina per la pubblicazione